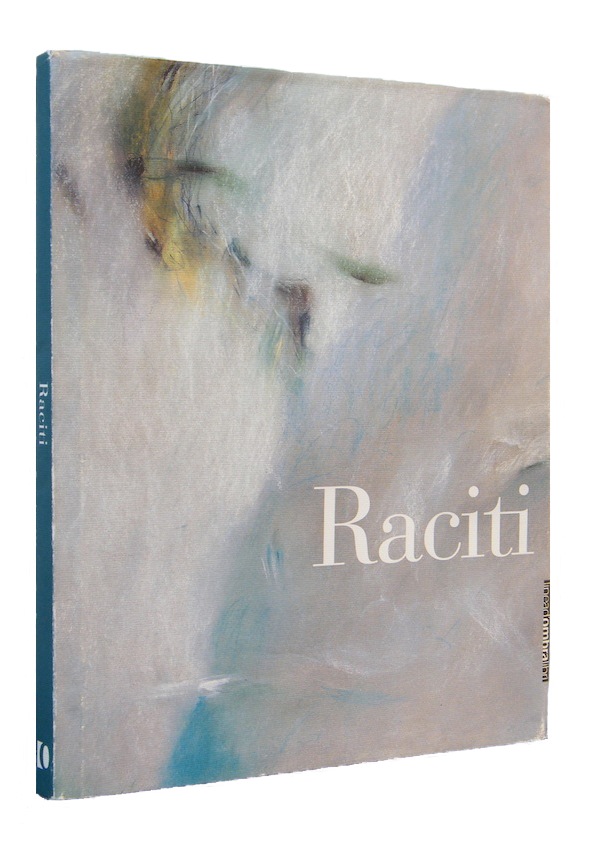
Nata dai rilievi fatti intorno ad alcuni miei versi del maggio 2001, questa conversazione con Guido Strazza tocca alcuni nostri comuni temi intorno al fare pittorico, alla magia delle sue tecniche che dicono la pittura e, al contempo, vanno oltre la pittura, nell’assunto che la pura materialità – la polvere di un colore, la lievità di un segno – trascende se stessa, ponendo interrogativi su “l’altro versante” delle cose.
Guido Strazza: Caro Mario, ho negli occhi, mi sembra da sempre, la tua pittura (mentre ti scrivo vedo un tuo pastello: due “fiammelle” al di là del blu?). Ne abbiamo tanto parlato stando zitti a guardare, ma per parlarne da lontano non restano che le parole – questa tua per cominciare: “dove siete anime?”. Ribalto a te la domanda. Dove vai anima quando cammini “tra siluri sirene e perle nere”? Ma c’è davvero un dove? Un blu o un’ombra nel quadro sono fantasmi o li nascondono? Nella “naturalezza” del mondo non stanno insieme, non sono tutt’uno, pietre e utopia, istanti e eternità?
Mario Raciti: “Dove ‘dove’ alla fine collocarlo?” Il dove sta nel superare l’angustia delle nostre piccole cose per inventare un altro spazio adeguato a quella parola: anima. Parola che pragmaticamente indica un che di inesistente, ma che comunque esprime moti che fanno di noi qualcosa di più del nostro ovvio quotidiano: sentire in noi un lato ignoto; respirare col mondo…
“Fare anima”: tutti, pragmatici o sognatori, ne abbiamo, oggi come mai, bisogno. Con semplicità, senza fanatismi. Fare anima cercando nella chiarità del mattino o nelle trasgressioni della notte. In tanti modi si può fare anima. Si può tentare – improvvisamente – sfarinando coi polpastrelli gessetti colorati su un foglio, ad evocare remoti bagliori…
G.S.: Pensiamo ai gessetti colorati. L’anima starà certamente più con loro che con i chiarori del mattino. Ma, in fondo, che cosa cerchiamo sfregando una polverina colorata su un foglio? Vogliamo decifrare i segni del mondo, capirne qualcosa, comprenderli, prenderli con noi? Ma non è sogno o astrazione perché i segni sono proprio lì, corporei, concreti, mutevoli nell’apparire e combinarsi, nascosti dovunque come nidiate di pensieri compressi, pronti a scappar fuori.
L’esser lì è loro verità, vederli e riconoscerli la nostra. Se la polvere è blu e le diamo il nome di notte, anche questa è una verità; ma potrebbe essere molte altre verità, potrebbe avere altri nomi. Sua vocazione è di poterne avere infiniti, la nostra di non negarne e, anzi, di alimentarne l’ambiguità che è ragione dell’essere artisti. Il punto è saper sempre riconoscere i significati “primi” del segno senza nome, quelli che, anche quando i nomi sovrapposti dalle diverse contemporaneità saranno esauriti, continueranno ad avere senso e significato.
Non per niente la pittura, proprio in quanto atto primo del segnare (e del significare), è vista oggi dagli addetti ai lavori mondani dell’arte come aliena a una “modernità” tutta contratta su una attualità che rifiuta ogni sogno di eternità. Così non direi che si può “improvvisamente” tentare di animare l’anima, nostra e del gessetto, strofinandolo su un foglio col polpastrello. Direi, invece, che non se ne può fare a meno e che è anzi la nostra prima, vera e fondata “naturalezza”.
M.R.: Come darti torto, Guido? Voglio confidarti una speranza. Quando, nel 1998, l’amico Baiocco, ospitandomi a Civitanova Marche, mi regalò una scatola di pastelli, non pensavo che avesse aperto le porte verso, per così dire, una mia nuova chiarezza. Non avevo mai sperimentato totalmente il pastello con la sua innata ricchezza di colore. In questo volume ne è riprodotto qualche precedente, peraltro di pastelli miscelati ad altre tecniche (Senza titolo, 1953; Quadrivio, 1956; Spiritello intercettato come crocefisso, 1967; Melisande, s.d.). Ma è solo dal 1998 che mi sono “aperto” unicamente alle cromie dei gessetti. Ciò combaciava con un mio regresso desiderio di canto (sono un amante del melodramma, che è canto aperto, pieno). Penso al canto come nostra risorsa nel bisogno, secondo Novalis, e wagnerianamente, come redenzione. Ebbene, le antinomie che sono sempre presenti nella mia pittura sono andate come attenuandosi nell’affabilità del colore. Anche se sono portato sempre alla ricerca di “punti estremi” (fisicamente, l’estate scorsa, sono stato con Mariangela a Capo Nord, ma il pensiero va a volte al di là delle ultime galassie…), il colore, col suo sfarinarsi, crea distanze, evoca presenze remote, sì, ma tutto questo è reso oggi in modo più caldo, direi più fiduciosamente vicino. Creare un contatto, qui e ora; donare…
G.S.: Mario, ho cercato di tenere a bada le parole alte e poetiche che tu usi con tanta naturalezza e sono un po’ a disagio perché, quando all’inizio ti chiedevo, con le tue stesse parole, “dove vai anima…?” avrei dovuto subito aggiungere “ma anch’io vado là, vengo anch’io!”, e non l’ho fatto. Per timore delle parole? Del mistero che nascondono e svelano? Mistero. Ecco di nuovo una tua parola! Però questa volta, visto che è il titolo delle tue opere, non posso non chiederti: perché “mistero”? Non è tutto chiarissimo? È vero, “il colore crea distanza…”, ma, comunque lo si usi, non crea distanza del qui ed ora assoluti dell’illuminazione? C’è qualcosa di più legato e compromesso con le cose dell’illuminazione?
M.R.: Mistero, perché non è tutto chiaro; ben lo sapevano gli antichi. Lo abbiamo detto, le polverine non sono che un mezzo. La pittura dice altro da sé. Profondo è il pozzo del voler conoscere, insondabile. Questa è una delle ragioni per cui il bello non è che l’inizio del tremendo. La razionalità pura penso sia un rifugio per timorosi. Se guardiamo dentro di noi, nei nostri sogni, non vediamo che antinomie, diversificazioni, strati. L’orizzonte si apre nel profondo su tante prospettive. Ed ecco perché una mia immagine non è solo “quella cosa lì”: è una bara, ma anche un fantasma bianco, un sommergibile, una capigliatura, un segno, un colore. Il centro, oggi, non esiste.
Ma che fare, se il petto si gonfia e hai voglia comunque di “cantare un bel canto”? Gettare fondamenta per una cattedrale senza altari. Attorno ad essa, nascerà domani una nuova città. Credere che in noi ci sia un desiderio d’anima. In quella cattedrale un dio, secondo Rilke, sarà. E se tutto ciò non avvenisse, canteremmo con Falstaff: “Tutto nel mondo è burla.”
G.S.: Sì, la pittura dice altro da sé, ma le polverine, le cose con le quali la maneggiamo, non sono solo un mezzo. Sono anche, di più, provocazione e origine dell’andare, del dove andare che, con la loro complicità umilmente cercata, speriamo di scoprire e riconoscere. L’illuminazione è l’istante misterioso della scoperta che, all’istante, ci rimanda ad altra illuminazione. E credo che il “tremendo” del bello non sia tanto nella sua insondabilità, quanto nella potenza della sua istantanea rivelazione; gli istanti sono infiniti. Intanto camminiamo. Non andrà male! Finché ci saranno polverine – e ci sono – e vedendole blu potremo chiamarle notte, tutto nel mondo sarà molto serio, non una burla.
M.R.: Sono lieto, Guido, del tuo ottimismo, come a stemperare i miei dubbi. Ma come fare quando la storia non permette di realizzare appieno certe urgenze? Ho la sensazione, a volte, di essere un piccolo don Chisciotte, ingenuamente fuori. Così va il mondo? Maurice Blanchot scriveva che i momenti più intensi dell’arte avvengono quando manca un qui vero, quando si vive nell’angoscia ed evocava il “cuore vuoto della ripetizione eterna”. Franco Rella, citando i miei segni leggeri e fragili, affermava che nella fragilità si ritrova la vera creaturalità: non c’è segno che esprima più compiutamente l’esistenza. Dal segno leggero alla sofficità e trasparenza del pastello, oggi. Ricordo che nel 1965 avevo intitolato un dipinto Elementi di una condizione. Quando si è costretti a esprimersi sottilmente, non può essere diversamente.
Intorno tutto urla. La pittura sembra perdere terreno perché è, per sua natura, anche nelle forme più esuberanti, sommessa, introspettiva. La pittura dice quello che non mostra; un orizzonte che non è l’orizzonte, un ciclo che non è mai il cielo. Guardare dentro. Oggi non c’è tempo. Bisogna raggiungere presto lo scopo. L’obiettività dell’oggetto rappresentato, o l’obiettività di una putrella, di un neon, di un sasso. Protagonista la cosa, la materia non riscattata.
L’arte è una soglia. Non si può sostare. Bisogna incamminarsi verso questa che è, spesso, una porta chiusa. Bisogna attivare le forze per vincerne la resistenza. Varcare la soglia può essere sconvolgente. Si deve tornare bambini, per i quali l’impossibile è normale. Argomentare su ciò che appare oltre la soglia non è dato. Là i parametri sono diversi. Non ci sono parole, c’è la visione.
G.S.: Tu parli in negativo di “protagonismo delle cose, della materia”. Ma loro sono i nostri complici, loro sono il nostro tramite, la cruna d’ago che dobbiamo infilare, la terra, il luogo infine, sul quale, per stare in piedi e camminare, dobbiamo poggiare i piedi. “Noi altri dipintori habbiamo da parlare con le mani”, diceva Annibale Carracci…
M.R.: Dietro di me sono allineate varie scatole di tempere Talens; il bianco lo preparo io con litopone, colla da parati e un pizzico di Vinavil; a volte uso polveri in vasetto e per certe rifiniture adopero i Winsor e Newton. Per spremere, miscelare, stendere, uso le mani. Annibale Carracci forse vorrebbe di più. Anche a me non basta. È proprio vietato riscattare la materia e tentare di ricavarne un pizzico di, ahimé impalpabile, poesia?
(in Raciti, I pastelli, a cura di Marco Goldin, Linea d’ombra Libri, Conegliano, 2001)